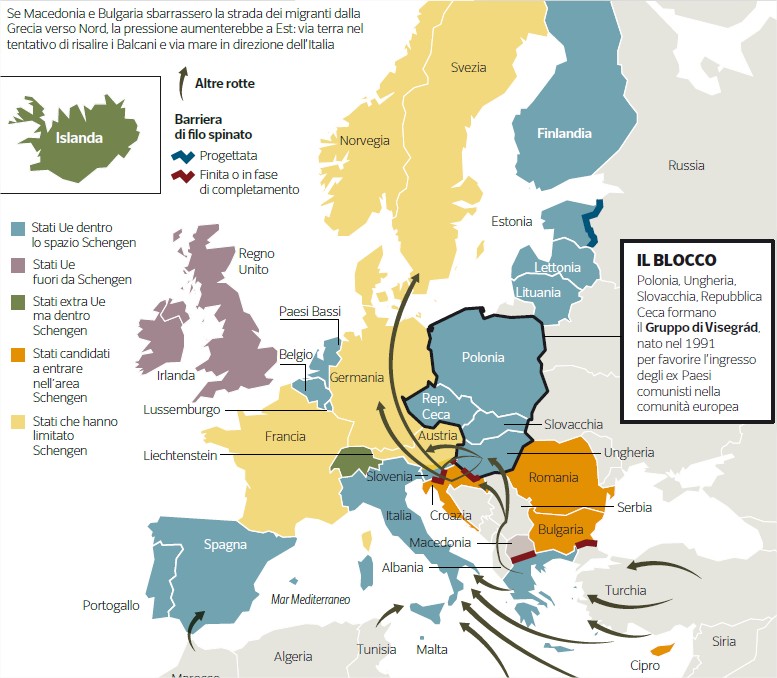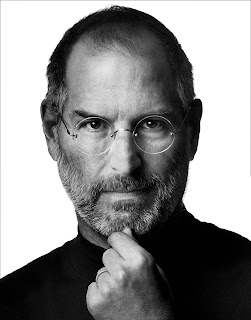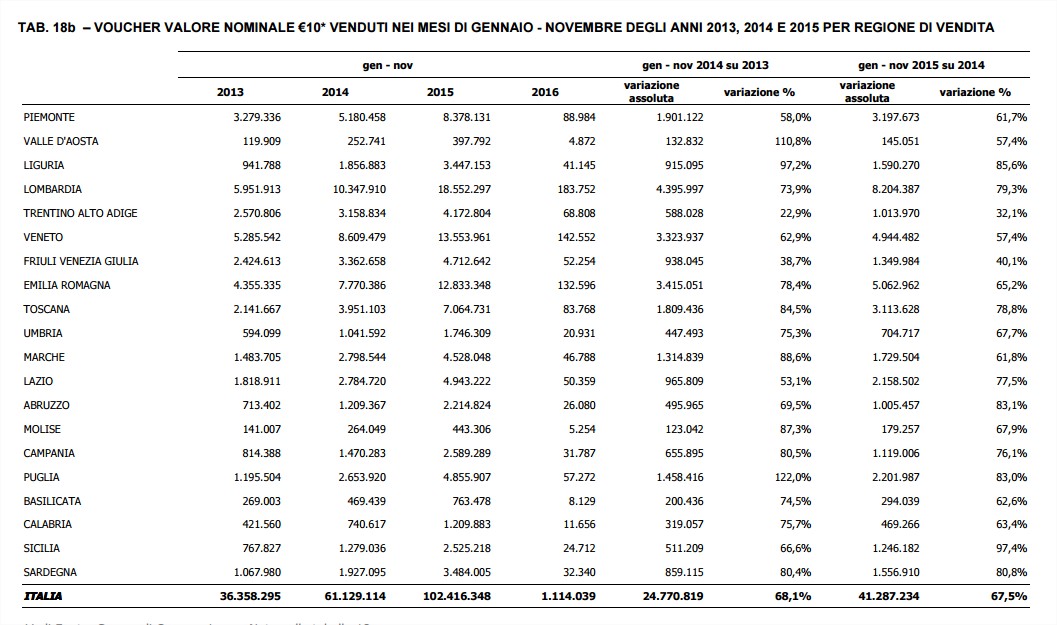Roberto Speranza: «Renzi è una
risorsa» (02/09/2013)
Goffredo Bettini: «Renzi è una
risorsa» (04/07/2013)
Erika D’Adda: «Renzi è una
risorsa» (04/05/2013)
Massimo D’Alema: «Renzi è una
risorsa» (20/07/2013)
Rosy Bindi: «Renzi è una risorsa»
(20/02/2013)
Pierluigi Bersani: «Renzi è una
risorsa» (03/12/2012)
Guglielmo Epifani: «Renzi è una
risorsa» (20/07/2013)
La minoranza dem che fa? «Si
costerna, s'indigna, s'impegna; poi getta la spugna con gran dignità»
risponderebbe con proverbiale schiettezza poetica Fabrizio De Andrè.
Vista la sua regolare cadenza, il
copione delle polemiche interne al Partito Democratico meriterebbe quasi di
essere postulato nei regolamenti parlamentari, precisamente a metà strada tra
l'approvazione in Consiglio dei ministri di un qualsiasi provvedimento e il suo
passaggio in Aula – ove bene che vada provvede la richiesta della fiducia a
sancire la fine dei giochi e ad ordinare il perfetto allineamento di una
compagine parlamentare dem che fino a qualche ora prima pareva sul punto di un
fatale «rompete le righe» di volta in volta divenuto sempre più monotono e
sempre meno sensazionale.
A distanza di due anni, quando su
determinante impulso proprio dell'allora componente anti-renziana del Pd la
Direzione votò a maggioranza bulgara un documento di benservito al governo
Letta (con tanto di aperitivi ordinati per l'occasione), quale che sia la
propria posizione politica appare arduo non sentire un senso di frustrazione di
fronte a questo ossessivo e futile brandire di pistole scariche da parte della
sempre più sparuta opposizione interna alla segreteria. Una rappresentazione
oramai ridotta a risaputa farsa, un consumato gioco di prestigio di cui tutti
gli spettatori conoscono il trucco. Un trucco, complice la bonaria onestà di
buona parte della minoranza, talmente evidente da essere stato ripetutamente
svelato: trattenere i tradizionali militanti dentro il corpaccione della
carcassa cadaverica del partito, dimostrando loro che un Pd ancora vagamente
immune alla pandemia neoliberale non solo sopravvive, ma potenzialmente gode
ancora della possibilità nientemeno che di tornare in sella. La battaglia della
minoranza, insomma, serve unicamente allo scopo di mascherare l'indole
smaccatamente di destra del partito garantendogli ancora la cigolante
possibilità di millantare tradizioni progressiste senza suscitare la risata
generale.
 |
| Una recente foto che ritrae gli esponenti di maggior spicco della minoranza interna al Pd (fonte) |
Il segretario ha solo da
gongolarsi di fronte ad un contesto abilmente manovrato – specie dagli apparati
mediatici – in cui la minoranza dem assurge a impacciata barricadera contro cui
scaricare agilmente ogni difficoltà e in cui l'unica opposizione con qualche
chance di vittoria alle elezioni è rappresentata dallo sgangherato populismo
anti-euro.
«Dopo di me il diluvio», può
affermare senza apparente timore di smentita il segretario Pd. «Dopo di lui il
diluvio», possono ripetere gli editoriali e la minoranza interna (i primi con
malcelato entusiasmo, la seconda con costruita rassegnazione) dimentichi che
tale motto apparteneva al Re Sole, certo non capostipite del liberalismo
democratico.
Disposti quindi ad un'opposizione
di modica quantità e ad una mobilitazione antigovernativa da coito interrotto,
gli esponenti della minoranza possono continuare a fregiarsi orgogliosamente di
non aver «tradito la ditta» e di voler ad ogni costo arginare l'incalzare
indotto della nauseabonda opposizione salviniana.
Successi di questa strategia non
paiono vedersene all'orizzonte: lungi dall'erigere un corposo argine, la destra
populista seguita a macinare consensi anche in versanti sociali verso cui la
sinistra non si pone più in ascolto. Il popolo erroneamente convinto che quell’ascolto
sarebbe giunto dal Pd disertano le urne - gonfiando lo spaventoso partito dei
rassegnati - e desertificano quelle che un tempo venivano chiamate «sezioni».
Assai pochi fedeli riesce ad
animare la fiaba di un Pd ove il renzismo viene raccontato come una nuvola
passeggera nel cielo terso di un partito vivace e legato alla sinistra. Troppo
sgualcito il sipario della (tragi)commedia di un campo progressista ove Renzi
più che un incidente di percorso appare sempre più nitidamente come l’esito
naturale di una dirigenza democratica da tempo disposta a tollerare con
benevolenza i giudizi sprezzanti verso il partito forte, indipendente ed
inclusivo. Disposta a tollerare da anni i richiami al plebiscitarismo ostile
agli organi di rappresentanza come prezzo da pagare per il successo elettorale.
Disposta troppo spesso con enfasi interessata a processare il Novecento (dietro
l'inconsistente retorica del «moderno») evocando una società dove i rapporti di
forza sono quelli dell'Ottocento. Indulgente nei riguardi di coloro talmente
accaniti nel denunciare il peggio della Prima Repubblica da condurre la
battaglia assieme al peggio della Seconda Repubblica. Persino nei confronti del
veleno berlusconiano, per usare le acute parole di Piero Ignazi, l'opposizione della sinistra
«si attivava a corrente
alternata: un giorno faceva la voce grossa, un altro trattava sulle frequenze
televisive, un giorno gridava al golpe, un altro cedeva sul “processo giusto”.
E così via. Mancava la costanza del resistere, resistere, resistere. E l'accusa
di antiberlusconismo veicolata dalla destra diventava quasi uno stigma da cui
difendersi. Non una onorevole connotazione etico-politica».
Il sostegno al governo Monti –
col suo bagaglio culturale magistralmente riassunto da quel passaggio di un
discorso di Angela Merkel secondo cui «la democrazia è accettabile solo se
conforme ai voleri del mercato» - avrebbe già dovuto far cogliere quanto questa
scelta fosse la pietra tombale di qualsiasi seppur pallida velleità di
sensibilità egualitaria da parte del Partito Democratico, definitivamente
suggellata da quel centinaio abbondante di parlamentari che scegliendo con
screanzata codardia di evitare la salita di Prodi al Quirinale sancì in tal
modo la propria incrollabile fedeltà al berlusconismo e sbarrò la strada non
solo a qualsiasi seppur ambigua altenativa di governo, ma anche alla possibilità
di un partito fondato su un’effettiva partecipazione.
Chi crede davvero nella necessità
di rigettare le nefaste politiche dell'ultimo ventennio ha già avuto ampiamente
modo di sperimentare che il Pd non rappresenta la propria casa, nemmeno se
possiede il volto della sua imbelle minoranza.